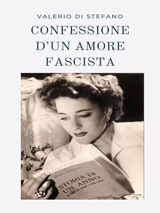
Amazon - Website

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Edizione di riferimento
Giacomo Leopardi, 1798-1998, Viaggio nella memoria, a cura di Fabiana Cacciapuoti, Electa, Milano 1999, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana ed il Patrocinio del Miniustero dei Beni Culturali e Ambientali; catalogo del Centro di Studi Leopardiani (Recanati) in collaborazione con Casa Leopardi
“Amore, amore, assai lungi volasti / dal petto mio, che fu sì caldo un giorno...” [1] L’amore, del quale pure cantò più volte l’epicedio (“questo gelido cor...” [2] etc. “Or poserai per sempre / stanco mio cor...“ [3] etc.), in realtà si spense con lui, nei giorni estremi della Villa Ferrigni, perch’egli fu sempre spasimato d’amore. Non tanto per le varie cugine e popolane, contesse e gentildonne, Gertrude e Teresa (anzi, le Terese della sua vita), la Berardinelli e la Brini, fino alla Fanny frivola e lusingatrice, che si prese gioco di lui. Non di esse qui si vuol parlare, né del contino infelice, della sua inattitudine a suscitare affetti, della redingote nera di abate mancato, della sua estraneità a Recanati che attraversava, le rare volte, con passo rasente i muri delle case, come a riparo dalle grida di scherno che la ragazzaglia scagliava alla sua gobba: né dell’incuria della persona crescente negli anni con l’indigenza e la trascuraggine, né dei malanni e degli spropositi alimentari che lo rendevano miserevole e perfino sgradito alla vista degli altri. Non di quelle pallide sinopie di amori, incarnazioni imperfette ed effimere che rivivranno poi d’altra luce nei nomi prestati dalla poesia: né del misero Giacomo si vuol parlare, ma della sua anima grande, invaghita della bellezza e dell’amore, nonostante con Teofrasto sapesse che l’una e l’altro erano la “tacita menzogna”, l’“inganno involontario” [4], che pure ci prende senza ripari di filosofia che ne preservi: anche se a lui, come alla misera Saffo, “di codesta infinita beltà parte nessuna... / i numi e l’empia sorte non fenno” [5]. Non di loro dunque, ma dell’idea che miseramente esse rappresentavano si dirà: e forse la donna di cui solo si parla è quella della canzone nota, il cui amore non comporta gelosie né raffronti, che vive negli spazi celesti tra le galassie, con la quale si corrisponde col telescopio [6]. Se negli anni giovanili confessava di essere “spasimato della gloria”, sempre, in seguito e per tutta la vita fu spasimato dell’amore, “la più dolce, più cara, più umana, più potente, più universale delle passioni” [7], “dolcissimo, possente / dominator di mia profonda mente: / temibile, ma caro / dono del ciel: consorte / ai lùgubri miei giorni...” [8], una delle cose belle che “altre il mondo non ha, non han le stelle” [9].
Il tema può sembrar frivolo o “sentimentale”’, ma a guardar bene si collega all’altro delle illusioni e della felicità, del bisogno d’infinito ch’è la nobiltà e la maledizione dell’uomo, a quella sua necessità di espansione "indefinita" che lo porta a nutrirsi anche consapevolmente d’illusioni, se vuol sfuggire all’inedia e al gelo degli affetti. Nello Zibaldone aveva annotato:
“Tutti i desideri e le speranze umane, anche dei beni ossia piaceri i più determinati, ed anche già sperimentati altre volte, non sono mai assolutamente chiari e distinti e precisi, ma contengono sempre un'idea confusa, si riferiscono sempre ad un oggetto che si concepisca confusamente. E perciò e non per altro, la speranza è meglio del piacere, contenendo quell’indefinito, che la realtà non può contenere. E ciò può vedersi massimamente nell’amore, dove la passione e la vita e l’azione dell’anima essendo più viva che mai, il desiderio e la speranza sono altresì più vive e sensibili, e risaltano più che nelle altre circostanze. Ora osservate che per l’una parte il desiderio e la speranza del vero amante è più confusa, vaga, indefinita di quella di chi è animato da qualunque altra passione: ed è carattere (già da molti notato) dell’amore, il presentare all’uomo un’idea infinita (cioè più sensibilmente indefinita di quella che presentano le altre passioni), e ch’egli può concepir meno di qualunque altra idea...” [10]
E non aveva detto nella Storia del genere umano che da Amore, unico Iddio pietoso, era venuta agli uomini la forza per non morire, per non disgustarsi del tutto della vita?
Un amore giovanile e senza seguito, più un giovanile invaghimento che un amore, quello per la cugina Gertrude: e certo, dai suoi svolgimenti tutti letterari, ci si convince che non poco debba avervi giocato un’autosuggestione amplificatrice, se non proprio creatrice, degli effetti e dei turbamenti oggetto di compiaciuta analisi: un gioco intellettuale spinto innanzi di proposito, con progressiva sostituzione d’immagine, da quella reale della formosa cugina con l’altra ideale, della sua mente, a svolgere il ruolo dell’oggetto d’amore, autonoma e disincarnata dalla creatura che le aveva dato vita. E però non è sensato sorriderne o restringerne l’eco interiore, ritenendolo collegato unicamente a quel mondo di libri e di fantasie di cui s’era nutrito fin allora il poeta.
Il fatto che l’occasione sia nello stesso tempo utilizzata per una analisi del processo e degli effetti dell’innamoramento, come nel Diario, o per alcune liriche d’amore, non deve apparire svalutativo della reale sofferenza di quel sentimento, ma ben naturale in un temperamento educato alle lettere che attendeva di fare le sue prove di penna in presa diretta, per così dire, sull’impulso di un sentimento per la prima volta veracemente sentito.
L’accurata e puntuale esplorazione di esso e degli effetti prodotti nel suo animo, s’accompagna alla scoperta di nuove dimensioni esistenziali e di orgogliose certezze, di cui si trova l’eco in taluni passi di lettere coeve, soprattutto al Giordani tra il dicembre del ’17 e il gennaio 1818, in cui scrive: “Oramai comincio, o mio caro, anch’io a disprezzare la gloria, comincio a intendere insieme con voi che cosa sia contentarsi cli se medesimo e mettersi colla mente più in su della fama e della gloria e degli uomini e di tutto il mondo. Ha sentito qualche cosa questo mio cuore per la quale mi par pure ch’egli sia nobile, e mi parete pure un vil cosa voi altri uomini, ai quali se per aver gloria bisogna che m’abbassi a domandarla, non la voglio: chè posso ben io farmi glorioso presso me stesso, avendo ogni cosa con me, e più assai che voi non mi potete in nessunissimo modo dare". Ed ancora: “... m’è accaduto per la prima volta in mia vita d’essere alcuni giorni per cagione non del corpo ma dell’animo, incapace e noncurante degli studi in questa mia solitudine” [11].
Siamo alle prime manifestazioni di quell’impegno conoscitivo e di quella esplorazione negli sterminati campi di una “scienza dell’animo umano” che ne costituirà il principale assunto. La consapevolezza improvvisamente disvelata, e nel Diario evidente, di aver scoperto una nuova dimensione dell’anima, di cui ora, finalmente, riusciva ad avere diretta esperienza, senza filtri né intermediari, si muta talora in puntigliosa analisi intellettuale, in meticolosa registrazione di fatti e di sentimenti, non senza lo stupore un po’ fanciullesco di chi può riconoscere dal finestrino della diligenza montagne, paesi e fiumi di cui aveva letto i nomi solo sugli atlanti. E l’amante/scrittore vi si slancia con quel suo giovanile agonismo, quasi volendo provare a se stesso il possesso di un’altra nobiltà e grandezza d’animo, autosufficiente nella sua esaltazione né bisognosa della gloria degli uomini, come il brano della lettera al Giordani dianzi riportata lascia intravedere.
Ciò non toglie che sotto quell’impegno un po’ rigido, un po’ ludico, si possano cogliere vibrazioni ancor vive, dolci e struggenti, riaffioranti dal fondo dell’anima più che dalla memoria, che egli voluttuosamente stringeva a ripetere, come da una moviola, il film degli accadimenti di quei brevi giorni: pochi, ma infiniti e foltissimi di eventi per l’attenzione di un innamorato.
Prende avvio la cronaca, attentamente registrata, dei primi freddi cominciamenti, delle timidezze orgogliose e dei silenzi: poi via via degli sguardi, delle invidie per i più disinvolti e fortunati conservatori familiari, dei giochi e degl’intrattenimenti della sera, con una conversazione che andava sciogliendosi, nel desiderio dell’attenzione e delle lodi della dama. Sembrava che tutto si disponesse nelle sequenze ben studiate di un gioco, ludico godimento di abilità, di conversazione, di sguardi.
Il primo senso di vuoto e di straniamento, segno inconfondibile della fenomenologia amorosa, si registra l’indomani, quando “nella mia votissima giornata aspettai il giuoco con piacere ma senza affanno”: venuta la sera, non mi passò per la mente ch’io ne potessi uscire malcontento“. Di tale scontentezza, seguita pure ad una cosa desiderata, di cui non poteva trovar di che rimproverarsi, non sapeva darsi ragione. Perché? Perché? Comincia il tormentoso domandarsi e rispondere, da sé a sé, in silenziose sequenze, alla ricerca di una spiegazione, ma anche, e soprattutto per ripercorrere il film della memoria e trovarne ancora dolcezze:
“Non sentito quel rimorso che spesso, passato qualche diletto, ci avvelena il cuore, di non esserci ben serviti dell’occasione [...] conosceva però benissimo che quel piacere era stato più torbido e incerto, ch’io non me l’era immaginato [...] e mi sentiva il cuore molto molle e tenero...” [12]
Ma d’improvviso, anzi, appena avuta coscienza di quel nuovo territorio che gli si apriva dinanzi, illuminato da un sole mai visto e più vivo di quello noto d’ogni giorno, ma anche insidiato da sorgenti d’affanno d’oscura scaturigine, la notizia della ormai decisa ed irrevocabile partenza della dama gli sottrae senza scampo ogni promesso piacere. L’evento ha la rapidità delle cose ineluttabili: non di restrizione o di termine annunciato si tratta, ma di esclusione e di fine definitiva, ché, al momento del congedo, quella stessa sera, “capii che sarebbe partita l’indomani, né io l’avrei riveduta”.
Una linea d’ombra e d’esclusione attraversa dunque la trama di quella giovanile avventura dell’animo, compartendone disugualmente lo spazio, ch’è tutto, o quasi, nella zona scura della memoria che s’attenua, del piacere reciso che lentamente rimargina, come una ferita, e non si vorrebbe, tanto sono care le ragioni di quel soffrire.
Tutto quel ricordare e minuzioso ricostruire annotando affinché nulla andasse perduto e potesse anzi servire al secondo e più vero suo essere nella sfera senza tempo di una possibile poesia, si svolge tra “inquietudine indistinta, scontento, malinconia, qualche dolcezza, molto affetto, e desiderio non sapeva né so di che...”: la moviola della memoria girava avanti e indietro il suo film, con improvvise accelerazioni, flashbacks e rallentyes, come avviene. Ed ecco l’angoscioso ritorno dei momenti più strazianti, i rumori della partenza nelle prime ore del mattino, lo scalpitare dei cavalli in attesa, l’orecchio avidissimamente teso” per sentire l’ultima volta la voce della dama: poi il silenzio immoto delle cose, il susseguirsi dei gesti e del rituale domestico d’ogni giorno, con un diaframma di gelo e di distacco, reso più assoluto nel raccoglimento teso a conservare, ad elencare ogni scaglia, ogni granello di quel sommovimento.
Vi è un passaggio in questa prima pagina scritta come una cronaca, che contiene già il sentimento angoscioso dell’annullamento di ogni cosa nel tempo, che sarà poi il tema straziato della Sera del dì di festa:
“un doloretto acerbo che mi prende ogni volta che mi ricordo dei dì passati, ricordanza malinconica oltre a quanto io potrei dire, e quando il ritorno delle stesse ore e circostanze della vita, mi richiama alla memoria quelle di que’ giorni, vedendomi dintorno un gran voto, e stringendomi amaramente il cuore” [13].
Nel quadro clinico ben noto, con svogliatezza, disinteresse per le cose già interessanti, inappetenza, turbamenti, inclinazione al silenzio, colloqui interiori, e via dicendo, una cosa prevale su tutte, ed è la preoccupazione di veder impallidire, fino a cancellarsi il sembiante della donna, e di sentir attenuarsi quei segni e straniamenti d’amore che pure nell’inquietudine, gli ripropongono a tratti, con la memoria, impressioni dolcissime.
Per chi era sempre e solo vissuto fin lì tra carte ed inchiostri, non poteva offrirsi altro rimedio che la scrittura:
“Volendo pur dare qualche alleggiamento al mio cuore, e non sapendo né volendo farlo altrimenti che collo scrivere [...] tentato il verso, e trovatolo restio, ho scritto queste righe...” [14]
Le paginette del Diario registrano i cedimenti ed i vuoti di quel fragile sentimento nell’animo del poeta, il quale deve riconoscere “come tutto al mondo passa, / e quasi orma non lascia” come dirà poi nella Sera. Solo il sonno, ed il sogno, qualche volta, inopinatamente, ma con struggente e ritrovata intensità, ripropongono emozioni e viste altrimenti celate.
Vi sono passaggi che meritano qualche attenzione, per certo indugio sui procedimenti del sonno e del sogno in un animo commosso, che richiamano già certi luoghi del Dialogo di Torquato Tasso: e perfino può sembrare di riconoscervi il nucleo generativo di alcuni versi e situazione poetica di assai più matura ed intensa consistenza: dico di alcuni versi della canzone Alla sua donna, là dove dice della bellezza “che amore / lunge m’inspiri o nascondendo il viso, / fuor se nel sonno il core / ombra diva mi scuoti”; ed ancora, poco più innanzi, “di te pensando, / a palpitar mi sveglio...”;
“Ogni sera, stando in letto e vegliando a lungo, con ogni possibile industria m’adopero di richiamarmi alla mente la cara sembianza, la quale probabilmente per questo appunto ch’io con tanto studio la cerco, mi sfugge, ed io non arrivo a vederne altro che i contorni, e ci affatico tanto il cervello che alla fine mi addormento per forza colla testa annebbiata infocata e dolente. Così m’accadde ieri sera, ma questa mattina svegliatomi per tempissimo, in quel proprio punto di svegliarmi, tra il sonno e la veglia spontaneamente m’è passata innanzi alla fantasia la desiderata immagine vera e viva, onde io immediatamente riscosso e spalancati gli occhi, subito le son corso dietro colla mente, e se non sono in tutto riuscito a farla tornare indietro, pure in quella freschezza di mente mattutina, tanto ne ho veduto e osservato e dell’aria del volto, e dei moti e dei gesti e del tratto e dei discorsi [...] che s’io avessi quelle cose tuttora presenti alla fantasia, sarei ben più smanioso e torbido ch’io non sono” [15].
Ormai alle notazioni della coscienza chiara e diurna, che non aggiungono molto a quanto già rilevato, si susseguono i momenti intensi del sogno, con la cara visione che ritorna a ravvivare una memoria consumata dalle sollecitazioni, dalle ricorrenze di gesti, di consuetudini, di giorni (“e in ispecie ieri sera giuocando e ricordandomi bene ch’era l’ottava di quel fatal giorno, presemi gagliardamente quel tristo pensiero, tanto ch’io n’alzai gli occhi verso quella parte dov’era stata la Signora per guardarla, com’avea fatto in quel turbolento giuocare, quasi ch’ella ancora ci fosse”), con insorgenze acerbe ed improvvise del sentimento altrimenti illanguidito.
L’uscita dall’angustia si dimostra evidente di lì a qualche giorno, e lo scrupoloso annotatore dei suoi sentimenti stenta a riconoscere il se stesso di prima, ordinato e preciso, disponibile alle occupazioni consuete, al leggere, al parlare, al ridere, che torna a prendere il posto del giovane straziato e straniato uscito da quella breve tempesta.
Sembra essere la notazione più triste: questa consapevolezza di un irrimediabile consumarsi della passione, anche la più forte e acerba, eppur non priva di dolcezza e di piacere vertiginoso nello straniamento: questo rientrare tra la gente comune, nelle abitudini d’ogni giorno, fuori ormai dal vortice affannoso ma esaltante che faceva diversi, e dunque in qualche modo grandi, Non rimane se non lo spazio ad alcune affermazioni puntigliose di assoluta fedeltà nella registrazione (“non ho in queste carte scritta cosa che non abbia effettivissimamente e spontaneamente sentita”), di non averla voluta in nessun modo buttare in letteratura (“ma sempre sincerissimamente detestando ogni ombra di romanzeria...”) e di non aver fatto ricorso, anzi di aver tenuto lontano i poeti d’amore (manco il Petrarca, comechè credessi che ci avrei trovato sentimenti somigliantissimi ai miei”).
Ma con chi si giustificava? A chi erano dirette quelle riflessioni? Non erano pagine di un diario? O pensava, com’è probabile, ad un romanzo autobiografico, di cui quelle carte erano prove, cartoni, ed abbozzi? Un romanzo di gloria, d’eroismo e d’amore, che potesse innalzarlo anche agli occhi di lei, quando l’avesse letto? Sono ipotesi non infondate. Ha scritto Gide che le plus grand bonheur après que d’aimer, est de confesser son amour” [16].
Quanto ebbe peso in questa stretta del cuore la cugina Gertrude e quanto un bisogno spasimato d'amore? Il nodo difficile a sciogliersi tra vita ed arte sembra stringersi ancor più a chi si volga a considerare questa ed altre vicende. Un nodo che se in apparenza può sembrare colleghi e renda indissolubili due comparti di una unitaria vicenda, in realtà mostra le distinzioni negli intrecci stessi più stretti, perché una cosa è la vita, altra cosa l'arte, finzione essa stessa creatrice di vita ma di altra vita, non importa se più reale e duratura nel tempo. I diaframmi tra vita ed arte hanno spessori diversi, sottili come il velo delle Grazie, talora più spessi di una muraglia: e però il velo nella sua trasparenza rimane quale distinzione, invalicabile diversità tra mondi dissimili che vicendevolmente si nutrono, ma ripugnano, non rinunciano in nessun caso alla reciproca autonomia. E nelle trasparenze s’intravede la filigrana di un immaginario che ha le sue leggi e su esse si sostiene anche quando sembra imitare la vita. Nella muraglia corrono fenditure, cunicoli di attraversamento, passaggi segreti che filtrano conispondenze. Un labirinto, nell’un caso e nell’altro, in cui si dipana il filo del testo, esile e ambiguo più di quello di Arianna.
Il teatro d’ombre della immaginazione e del desiderio trovava spazi congeniali nei chiaroscuri indefiniti dei versi. Chi era, e quali legami d’amore tenevano “la donna mia” della Sera del dì di festa che non sa né pensa “quanta piaga m’apristi in mezzo al petto”, per la quale il poeta piange e si dispera e non s’illude di poterle occorrere nei pensieri del sonno? Ombre, fantasmi del cuore e della mente che non trovano se non sbiadite sinopie nelle notazioni dei Ricordi d’Infanzia e d’adolescenza:
“sogni amorosi, amore per la balia, per la Millesi [...] amore, amore, cantato dai fanciulli (leggendo io l'Ariosto) [...] grida delle figlie del cocchiere [...] storia di Teresa da me poco conosciuta e interesse ch’io ne prendeva come di tutti i morti giovani... Canto delle figlie del cocchiere e in particolare di Teresa [...] mio amore per la Broglio monacatesi [...] donne che spandono panni [...] vista già tanto desiderata della Brini ec. Mio volermi persuadere da principio che fosse la sorella quantunque io credessi il contrar persuaso da Carlo ec. suo guardare spesso indietro al padrone allora passato, ec. correr via frettolosam. con un bel fazzoletto in testa vestita di rosso e qualche cosa incolto in un fazzoletto bianco in una mano ec. nel suo voltarsi ci voltava la faccia ma per momenti ed era istabile come un’ape: si fermava qua e là, diede un salto per cedere il giuoco del pallone ma con faccia seria e semplice [...] noi andarle dietro finché fermatasi ancora con alcune donne si tolse (non già per civetteria) il fazzoletto di testa e gli passarono presso in una via strettiss [...] miei pensieri la sera turbamento allora [...] Riveduta la Brini senza sapere ed avendomi anche salutato dolcemente (o ch’io me lo figurai) ben mi parve un bel viso e perciò come soglio domandai chi era [...] e saputolo pensa com’io restassi e più nel vederla poco dopo a caso nello stesso passeggio: dico a caso perché io stava sulle spine [...] affine di andare in luogo dove potessi rincontrarla ma invano finché tornandomi lasciata troppo tardi la compagnia e senza speranza la rividi pure all’improvviso, sogno di quella notte e mio vero paradiso in parlar con lei ed esserne interrogato e ascoltato con riso ridente e poi domandarle io la mano a baciare ed ella torcendo non so di che filo porgermela guardandomi con aria semplicissima e candidissima ed io baciarla senza ardire di toccarla con tale diletto ch’io allora solo in sogno per la primissima tolta provai che cosa sia questa sorta di consolazioni con tal verità che svegliatomi subito e riscosso pienamente vidi che il piacere era stato appunto qual sarebbe reale e vivo e restai attonito e conobbi come sia vero che tutta l’anima si possa trasfondere in un bacio e perder di vista tutto il mondo ...” [17]
E l’appunto, relativo al 1819, il suo annus horribilis: accidia e freddezza e secchezza del gennaio ec. insomma del carnevale del ’19 dove quasi neppure la vista delle donne più mi muoveva... [18].
Notazioni, pagine della memoria (o sogni anch’essi?) da servire forse per un romanzo: e intanto offrivano materia trasferendosi nello spazio della poesia trascendendo occasione e referente iniziale, trovando nella letteratura e nei suoi modelli il luogo proprio di espressione, senza perdere peraltro quel tanto di patetico e di vero che poteva esserne stata la radice.
Così nel Sogno, alcuni anni dopo, una linea d’ombra, allucinata e straziante, separa il mondo delle care larve viventi dentro di noi, levate d’improvviso a scuotere dal torpore d’ogni giorno con un fremito che lascia solchi dolorosi nell’anima, e la realtà riaffiorante nel doloroso risveglio. Una linea che divide due zone d’anima, che non hanno tramiti di corrispondenza tra loro, se non nelle zone franche, eppur effimere ed illusorie, della rêverie, o in quelle più angosciose del sogno.
Il componimento non ha incontrato il gusto dei critici, che ne hanno rimarcato la letterarietà e le zone opache, soprattutto nel confronto con il livello più maturo e suggestivo dei versi A Silvia, sogno anche questo di una ricordanza acerba, di un’altra di queste sue donne “mancanti”. Ma proprio tale inclinazione al giudizio estetico ed al confronto ha fatto trascurare altri elementi, che vanno dai livelli di svolgimento del tema della morte in giovane età, del funere acerbo così ossessivo in questa poesia, alla forza patetica del tema più generale della esclusione da un possesso, sentito come trauma e ferita irrisarcibile: che è tema centrale di tutta la poesia leopardiana, in questo caso trauma del poeta/personaggio, per quella suggestione amorosa, e della donna che se ne dichiara partecipe, ma soprattutto per la vita sfuggita nei più giovani anni. Così in una forma letteraria, ma più esistenziale, ancora dolorosa e patetica, si svolge il tema misterioso e straziante della vita e della morte, di chi resta e di chi parte, dell’amore, del miraggio di felicità e bellezza che crudelmente ci è tolto: si svolge nelle sospensioni del sogno, nelle zone nebulose dell’anima in cui s’incontrano le pulsioni del desiderio e i traumi dei mancamenti, con tutta la forza non rasserenata che porta al grido e al pianto; mentre nella rassegnazione degli anni, in un "calor di fiamma lontana", lo stesso tema sarà svolto non solo e non tanto in A Silvia o nelle Ricordanze, quanto nella canzone Sopra un basso rilievo antico sepolcrale in cui l’intendimento speculativo solo in parte contrasta il ritorno di pena per una condizione umana non accettata, per un’antica ferita non ancora, né mai rimarginata.
Gli spunti dei Ricordi d’infanzia e d’adolescenza, relativi soprattutto alla Brini ed al sogno del bacio, sembrano offrire riferimenti autobiografici a questa fantasia romantica. Quei frantumi di vita e di sentimento si trasformeranno in nuovi fantasmi vivi e presenti. L’epicedio di Silvia sarà l’epicedio della giovinezza, sua e di tutti, del sogno d’amore e di vita, della speranza giovane; la sua morte, come è stato detto, è rappresentata non come già avvenuta, ma destino irrevocabile e comune, imposto al genere umano da “ferrata necessità”. La visione del Sogno appartiene invece alla zona più autobiografica della sua giovinezza mai vissuta, con prevalente attrait sentimentale, senza significazioni di simbolo o distanziamenti intellettuali, come sarà per Silvia e per la fanciulla della prima “sepolcrale”.
Quel fantasma di donna che “stettemi allato e riguardommi in viso”, evocato dalle profondità dell’Erebo dei sogni per un ritorno improvviso di vita, non può dirsi chi sia; ma non è nella nanna dei sogni di corrispondere a una stratigrafia divaricata e contraddittoria d’immagini tenute insieme con forza da misteriose ipnotiche pulsioni interiori?
Di questa sappiamo soltanto per certo che non è solo un fantasma di sogno, ma di qualcuno che, sia pure nella “finzione” della poesia, con la morte ha lasciato un vuoto inaccettabile ed inaccettato dalla coscienza ferita di chi l’amava. Ma nel sogno, illusoriamente, secondo desiderio, la morte si trasmuta in vita, anche se “trista, e quale / degl’infelici è la sembianza”.
Non è questo peraltro il nucleo “sentimentale” dell'elegia. Come non è la diatriba, contro la condizione dolorosa dell’uomo e la nequizia delle leggi di Natura, anche se essa fa registrare argomenti e stilemi già tutti leopardiani. Il nucleo patetico è altrove, ed altrove il generatore lirico dei versi: in quella straziata non accettazione dell’evento luttuoso che esclude da una condizione felice o almeno amorosa, e dunque vitale, ed opera nel profondo, con attraversamenti repentini delta soglia dell’Erebo, con restituzione di vita alle ombre di morte: in quella rimozione dell’evento inaccettato che ripropone più volte nel sogno e nei laghi oscuri dell’anima l’impressione di una persistenza di vita, la stupida e provvisoriamente liberatoria scoperta di un errore di notizia, la restituzione di una presenza, che certo provoca stupore (“Donde, risposi, e come, vieni, o cara beltà?”, vv. 13-14), ma riannoda il filo dei discorsi e delle speranze, dei desideri e dei timori che sono dei vivi (“Ma sei tu per lasciarmi un’altra volta?... / / Or dimmi, e che t’avvenne?”, vv. 19-20).
Il poeta/personaggio del Sogno ha attraversato la linea d’ombra, è già tutto di là, nella zona luminosa dell’incontro e del desiderio: sono dietro di lui, provvisoriamente, le esclusioni e la solitudine; quell’immagine d’amore, quella corrispondenza di discorsi mai fatti se non nel recinto chiuso del cuore, è ora dinanzi a lui, in una reintegrata, miracolosa dimestichezza d’affetti e quasi consuetudine di vita. Le forze del desiderio, spezzando i cancelli della morte, hanno liberato fantasmi consolatori, ed essi hanno preso sembianza e voce conforme a quel desiderio: il regno doloroso del reale s’è mutato in quello liberato dell’immaginazione e del desiderio; il sogno, con le sue ombre diafane, stupefatte ed allucinate nel chiarore del primo indistinto mattino, compie il miracolo in una sospensione irreale, che al cuore è più che realtà. Si ripete, anzi, s’anticipa la dimensione sospesa di certi versi della canzone Alla sua donna e di certe pagine dell’operetta di Tasso e del suo Genio familiare.
La morte e la vita, come nella “sepolcrale”, divise ancora irrimediabilmente da quella linea d’ombra invalicabile e crudele, che separa le cose presenti e possedute, dalle passate e perdute, una separatezza e una distanza incolmabili (“Dunque sei morta... / ed io son vivo..., vv. 39-40).
Riaffiora così nella illusione del desiderio e nella campitura del sogno, la delicata trama di una corrispondenza d’amore ignorata, forse neppure sperata, le notti e i giorni tratte “nel vano dubitar”, il sorriso schivo di lei nell’assicurazione d’amore e nel concedersi per un istante al contatto, ad una piena e desiderio di baci, all’abbraccio, che segna il momento emotivo più alto e la fuoruscita da quell’Elisio di sogno. La linea d’ombra e di morte non poteva esser varcata durevolmente, se non nell’istantanea illusione del desiderio: già cigolavano chiudendosi le ferrose porte dell’Erebo, quell’Euridice si volgeva pietosa, prima di andare (“già scordi, o caro, disse, che di beltà son fatta ignuda?”): prima di scomparire senza scampo, lei ormai d’altro mondo e d’altra vita, più fredda ed estranea, eppure nell’illusione del desiderio memore di lui e pietosa: “E tu d’amore, o sfortunato, indarno / ti scaldi e fremi. Or finalmente addio,” (vv. 90-91).
Dai blocchi di migliaia di pagine di Zibaldone, nel ’23, sulle soglie di un lungo silenzio della poesia, quasi un commiato da un’epoca della vita e un viatico per il lungo attraversamento del deserto degli affetti, si levano i versi della canzone Alla sua donna, idea platonica dell’amore, inno ed elegia insieme ad un ideale assoluto di felicità e struggimento per la conclamata inattingibilità di esso.
Quale Proserpina o Euridice salutava, dunque, nel profondo del viaggio, avviandosi verso plaghe illuminate da un freddo sole intellettuale? Quale saluto, disperato e disilluso, ironico e intrepido? e per chi?
Chi era quella cara beltà che si salutava? forma ripresa dal Sogno, v. 14, ma di molto innalzata nella rarefatta e ideale bellezza, rispetto alla lacrimosa e “privata” visione dell’elegia precedente, anch’essa, peraltro, non per mera coincidenza, fantasma di forti emozioni oniriche: “nel sonno il core / ombra diva mi scuoti”, “di te pensando, / a palpitar mi sveglio”. E però nella tessitura sorvegliata delle strofe, affidate al modello di un vitreo Petrarca appena attraversato da increspature patetiche sotto la patina d’ironica freddezza razionale, immagini, ricordi, desideri, cose sognate o sperate, moti del cuore, istanze filosofiche si coagulavano nell’idea della donna e del sentimento d’amore: per cui ben poteva dire nelle Annotazioni che
“la donna, cioè l’innamorata, dell’autore, è una di quelle immagini, uno di quei fantasmi di bellezza e virtù celeste e ineffabile, che ci occorrono spesso alla fantasia, nel sonno e nella veglia [...] o in una quasi alienazione della mente, quando siamo giovani, Infine è la donna che non si trova [...] L’autore [...] la cerca tra le idee di Platone, la cerca nella luna, nei pianeti del sistema solare, in quei de’ sistemi delle stelle [...] e sarà pur certo che questo tale amore non può né dare né patire gelosia, perché, fuor dell’autore, nessun amante terreno vorrà fare all’amore col telescopio”.
Ma proprio per questa sua assolutezza astratta e metafisica la canzone esprime la più alta forma della passione amorosa del poeta, ed ha un confacente andamento di una sonata d’archi, limpida e disperata nella scansione delle strofe e dei tempi: di una tristezza profonda ma chiara, come consapevole di uno scavo fin in fondo alla nozione che in fatto d’amore (e di felicità) non si consente di nutrire se non utopiche ed improbabili immaginazioni; e però non senza resistenti palpiti e commovimenti del cuore. Il leitmotiv delle speranze deluse, della inaridita condizione umana trova riscatto nello slancio di una speranza assurda: “e potess’io...”. Ma neppur l’ombra di quel miraggio è attingibile, non rimane se non la possibilità di un saluto: “Questo d’ignoto amante inno ricevi” [19]: una chiusa apparentemente ingegnosa e come dominata dall’ironia, in cui s’addensa peraltro tutta la patetica tensione del canto, anzi dell’inno, che si chiarisce in una originale ed un po’ enigmatica dimensione ironico/intellettual/sentimentale.
Dopo, negli anni delle erratiche residenze bolognesi, fiorentine, pisane, romane, l’amore poté prendere forma e nome, ma dietro quelle immagini era sempre l’antica idea, l’illusione impossibile, l’inganno involontario del quale conosceva i meccanismi, ma cui non si negava, come già Teofrasto, per un bisogno di sopravvivenza vitale. E già da tempo aveva compreso della irresistibile presa che aveva sugli animi la bellezza e l’amore:
“Non v’è uomo così certo della malizia delle donne ec. che non senta un’impressione dilettevole, e una vana speranza all’aspetto di una beltà che gli usi qualche piacevolezza...” [20]
Nel Risorgimento, dopo anni di gelo del cuore, dichiara quasi con meraviglia di sentire ancora “i dolci affanni, i teneri moti del cor profondo”: lo incantano di nuovo pupille tenere sguardi furtivi, erranti” [21], la vista di una “candida ignuda mano” lo commuove. Naturalmente conosce bene che nulla è più, né può essere, come prima: che la stagione dei palpiti e degl’inganni è definitivamente svanita. Anche gl’inganni d’amore, nello specifico ed in astratto, non possono più illuderlo; almeno pensa debba essere così (“E voi, pupille tremule, / voi raggio sovrumano, / so che splendete invano, / che in voi non brilla amor” [22]). E tuttavia la bellezza e il gioco degl’inganni è dilettevole in sé, alimenta la vita del cuore, dà ebbrezze altrimenti sconosciute, che nessuna consapevolezza potrebbe risarcire: “Pur sento in me rivivere / gl'inganni aperti e noti / e de’ suoi proprii moti / si meraviglia in sen” [23]. Chi avrà mai prodotto questo risorgimento? V’è l’ombra della Malvezzi, della Lucignani, della Saccà? Chi può dirlo? V’è certo un bisogno espansivo d’amore che è il bisogno stesso di tenersi stretto alla vita.
Ripensando pochi mesi dopo, tornato in Firenze, a quella primavera pisana del 1828, alle sue ombre amorose e forse oltre che a Silvia, ad un’altra Teresa, la giovinetta Lucignani che s’incantava a vedere per casa, esce in questo pensiero sulla grazia acerba e "divina" delle adolescenti:
“Una donna di 20, 25 o 30 anni ha forse più d’attraits, più d’ illecebre, ed è più atta a ispirare, e maggiormente a mantenere, una passione, Così almeno è paruto a me sempre, anche nella primissima gioventù: così anche ad altri che se n’intendono (M. Merle), Ma veram. una giovane dai 16 ai 18 anni ha nel suo viso, ne’ suoi moti, nelle sue voci, salti ec. Un non so che di divino, che niente può agguagliare. Qualunque sia il suo carattere, il suo gusto: allegra o malinconica, capricciosa o grave, vivace o modesta: quel fiore purissimo, intatto, freschissimo di gioventù, quella speranza vergine, incolume che gli si legge nel viso e negli atti, o che voi nel guardarla concepite in lei e per lei: quell’aria d’innocenza, d’ignoranza completa del male, delle sventure, de’ patimenti, quel fiore insomma, quel primissimo fiore della vita: tutte queste cose, anche senza innamorarvi, anche senza interessarvi, fanno in voi un’impressione così viva, così profonda, così ineffabile, che voi non vi saziate di guardar quel viso, ed io non conosco cosa che più di questa sia capace d’elevarci l’anima, di trasportarci in un altro mondo, di darci un’idea d’angeli, di paradiso, di divinità, di felicità...” [24]
Dopo le ombre amorose di Silvia e di Nerina, fantasmi della memoria ma subito sollevati a funzioni simboliche di una dolorosa fuoruscita dall’età dorata della giovinezza e della caduta delle speranze, perfino nei versi di Aspasia, che pure risentono di un intento di rivalsa intellettuale nei confronti di un legame ch’era anche un inganno, la dolcezza dell’inganno s’aggruma nel ricordo delle grazie di Fanny, per lui delizia ed erinni: gli odori della primavera, la donna “del color vestita della bruna viola”, l’angelica sua forma, le curve labbra, il niveo collo, la man leggiadrissima. La memoria indugia su quelle immagini e sui trascorsi ormai lontani di quell’amore, di quel suo amore del quale intellettualmente si affanna a spiegare l’inganno prodotto dalla sovrimpressione che immancabilmente operiamo di un fantasma della nostra mente all’amata persona reale. Può ben dire che ormai “qui neghittoso immobile giacendo, / il mar la terra e il ciel miro e sorrido” [25]. In realtà l’ondulato e circolare svolgimento della lirica, i lunghi indugi sensuali di memoria, sembrano dire il contrario. Il sorriso intellettuale celebra la sua vittoria sullo straniamento ed inganno dell’amore, dalla mente rischiarata distillano orgogliose rivalse e puntigliose distinzioni. Nel deserto degli affetti almeno la quiete dell’anima dovrebbe essere sicura. Come se potesse bastare! Ma le porte dell’Ade restano aperte ai sogni e alle memorie. Sono fantasmi che vengono improvvisi e s’avvinghiano al cuore. Comprendeva che anche nelle cose dell’animo nulla finisce mai veramente e tutto continua di una sua vita che può tornare intensa all’improvviso, inaspettatamente, per un rinnovato incontro. Almeno sino alla fine.
Note
____________________________
[1] La vita solitaria, vv. 39-40.
[2] Alla Primavera, v. 18.
[3] A se stesso, v. 1.
[4] G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W, Binni, Firenze, Sansoni, 1969: p. 306.
[5] Ultimo canto di Saffo, vv. 20-23.
[6] Annotazioni dell’Autore alla canzone Alla sua donna.
[7] Zibaldone, cit. 3611, del 3-6 ottobre 1823.
[8] Il pensiero dominante vv.15.
[9] Amore e Morte, v. 4.
[10] Zibaldone, cit. 1017 del 6 maggio 1821.
[11] Cfr, Epistolario, in Tutte le Opere, cit.
[12] Diario del primo amore.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15]Ibidem.
[16] Per un più puntuale dettaglio interpretativo in questa chiave di lettura di questo e di altri testi poetici di Leopardi, rimando al mio volume La linea d’ombra. Note sulla elegia di Leopardi, Fasano, Schena, 1994.
[17] Ricordi d’infanzia e d’Adolescenza, in Tutte le Opere, cit.
[18] Ibidem.
[19] Alla sua donna, v. 55.
[20] Zibaldone, cit. 1651, il 9 Sett. dì della natività di Maria SS. 1821.
[21] Il Risorgimento, vv.57-58.
[22] Ibidem.133-136.
[23] Ibidem. vv. 145-148.
[24] Zibaldone, cit. 4310. Fir. 30 giu. 1828.
[25] Aspasia, vv. 111-112.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| © 1996 - Tutti i diritti sono riservati Biblioteca dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2008 |