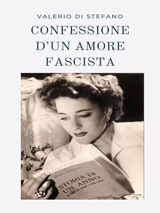
Amazon - Website

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Edizione di riferimento
Giacomo Leopardi, 1798-1998, Viaggio nella memoria, a cura di Fabiana Cacciapuoti, Electa, Milano 1999, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana ed il Patrocinio del Miniustero dei Beni Culturali e Ambientali; catalogo del Centro di Studi Leopardiani (Recanati) in collaborazione con Casa Leopardi
«Sombre amant de la Mort» venne chiamato Leopardi da Alfred De Musset [1], e la facile etichetta ispirata ad Amore e Morte bloccò, dove attecchì, la corretta valutazione del problema, non soltanto perché lo ridusse ai termini predecadenti di un cupio dissolvi, ma perché lo chiuse in un cerchio tautologico identificando il concetto con la persona. Fuori restava la ricca riflessione teorica che, disseminata in Operette e Zibaldone, accompagna il percorso dei Canti conferendo al cordis affectus il rango di vero e proprio filo conduttore: dapprima come celebrazione e fine dell’antico nesso fra bellezza e virtù (Nelle nozze della sorella Paolina, Ultimo canto di Saffo) [2], poi — per attenerci al tracciato del libro — come travaglio attorno al moderno amore “sentimentale” vissuto in corpore vili,secondo un itinerario che parte dal Primo amore,prosegue in crescendo con Il sogno, Consalvo,e Alla sua donna,fino a raggiungere la vetta bipartita del Pensiero dominante e di Amore e Morte, per concludersi nel segno del disinganno con Aspasia e Sopra il ritratto di una bella donna [3].
Elemento di un “sistema” ideologico bipolare, l’amore leopardiano appare, non meno di quello cortese, associato a coppie antinomiche (la vita e la morte, la noia e la bellezza, il piacere e il dolore e così via), la cui incompatibilità annulla per via ossimorica, potenziando nel contempo l’enueg e l’esaltazione vitalistica, il senso di vuoto e la pienezza dell’immaginazione. Basterà ricordare a questo proposito la duplice qualità, privativa ed appagante, assegnatagli all’altezza del Primo amore: [4]
Dimmi, tenero core, or che spavento,
Che angoscia era la tua fra quel pensiero
Presso al qual t’era noia ogni contento?
(vv. 13-15
Vive quel foco ancor, vive l’affetto,
Spira nel pensier mio la bella imago,
Da cui, se non celeste, altro diletto
giammai non ebbi, e sol di lei m’appago.
(vv. 100-103)
e ribadita nel Pensiero dominante con un ulteriore potenziamento del suo carattere estremo:
Che intollerabil noia
Gli ozi, i commerci usati,
E di vano piacer la vana spene,
Allato a quella gioia,
Gioia celeste che da te mi viene!
[...]
Che mondo mai, che nova
Immensità, che paradiso è quello
Là dove spesso il tuo stupendo incanto
Parmi innalzar!
(Il pensiero dominante, vv. 24-28: 100-103)
La guida capace di orientarci nel labirinto, risiederà perciò nella parafrasi “inganno estremo” con cui il poeta definì la passione in A se stesso e che, se da un lato la include tra i “leggiadri errori” capaci di abbellire la vita, dall’altro la separa per la forza eccezionale del miraggio che — subentrato all’esaurirsi d’ogni altra illusione — porta le ultime possibilità del paradosso ai limiti di rottura. Ciò converte l’esperienza erotica nel banco di prova del sistema stesso, la cui originalità si misura in buona parte sullo sfondo della tradizione platonica e stilnovistica alla quale rinvia palesemente il linguaggio dottrinale di certi canti, per nulla inferiore in sottigliezza ai lambiccamenti del trobar plus.
Dell’alto grado di consapevolezza teorica implicito nella riflessione leopardiana sull’amore, dànno conto alcuni appunti dello Zibaldone che affrontano la questione del desiderio erotico in rapporto alla “teoria del piacere”:
Dalla mia teoria del piacere seguita che l’uomo, desiderando sempre un piacere infinito e che lo soddisfi intieramente, desideri sempre e speri una cosa ch’egli non può concepire [...] perciò e non per altro, la speranza è meglio del piacere, contenendo quell’indefinito che la realtà non può contenere. E ciò può vedersi massimamente nell’amore, dove la passione e la vita e l’azione dell’anima essendo più viva che mai, il desiderio e la speranza sono altresì vive e sensibili, e risaltano più che nelle altre circostanze. Ora osservate che per l’una parte il desiderio e la speranza del vero amante è più confusa, vaga, indefinita che quella di chi è animato da qualunque altra passione: ed è carattere (già da molti notato) dell’amore, il presentare all’uomo un’idea infinita (cioè più sensibilmente indefinita di quella che presentano le altre passioni) e ch’egli può concepir meno di qualunque altra idea ec. Per l’altra parte notate, che appunto a cagione di questo infinito, inseparabile dal vero amore, questa passione in mezzo alle sue tempeste, è la sorgente de’ maggiori piaceri che l’uomo possa provare (Zib. 1017, 6 maggio 1821. corsivo di L.).
dove all’incremento di vitalità corrisponde la superiore indefinitezza dell’oggetto, ottenendo come risultato due paradossi: il carattere “sensibilmente indefinito” dell’idea (con implicito richiamo all’ossimoro sensibile incorporeo) e la possibilità di “concepire” ciò che la realtà “non può contenere”. con la conseguente sproporzione tra l’immagine mentale e la forma reale, tra il pensiero e la cosa pensata.
Che il corpo di una bella donna – suscettibile a sua volta di pensieri e desideri – risulti meno facilmente trasformabile in “infinito” degli spazi immaginati oltre ll paesaggio, lo dimostra il tentativo di assimilare i due processi in altro appunto di data posteriore:
Quanto influisca sempre l’immaginazione, l’opinione, la prevenzione ec. sull’amore anche corporale, sui sentimenti che un uomo prova in particolare verso una donna, o una donna verso un uomo, è cosa notissima. E in particolare ha forza sull’amore, non solo platonico o sentimentale, ma eziandio corporale verso gl’individui particolari, tutto ciò che ha del misterioso, e che serve a rendere poco noto all’amante l’oggetto del suo amore, e quindi a dar campo alla sua immaginazione di fabbricare, p. dir così, intorno ad esso oggetto. Perciò moltissimo contribuisce all’amore e al desiderio anche corporale, tutto ciò che ha relazione ai pregi o alle qualità comunque amabili dell’animo nell’oggetto amabile, e in particolare un certo carattere profondo, malinconico, sentimentale, o un mostrar di rinchiudere in se più che non apparisce di fuori. Perocchè l’animo e le sue qualità, e massimamente queste che ho specificate, son cose occulte, ed ignote all’altre persone, e dan luogo in queste all’immaginare, ai concetti vaghi e indeterminati: i quali concetti e le quali immaginazioni congiungendosi al natural desiderio che porta l’individuo dell’un sesso verso quello dell’altro, danno un infinito risalto a questo desiderio, accrescono strabocchevolmente il piacere che si prova nel soddisfarlo: le idee misteriose e naturalmente indeterminate, che hanno relazione all’animo dell’oggetto amato, che nascono dalle qualità e parti apparenti del suo spirito, e massime se da qualità che abbiano del profondo e del nascosto e dell’incerto, e che promettano o dimostrino altre lor parti o altre qualità occulte ed amabili ec. queste idee dico, congiungendosi alle idee chiare e determinate che hanno relazione al materiale dell’oggetto amato, e comunicando loro del misterioso e del vago, le rendono infinitamente più belle, e il corpo della persona amata o amabile, infinitamente più amabile, pregiato, desiderabile: e caro quando si ottenga (Zib. 3909-3910. 26 novembre 1823) [5].
Perché, traducendo l’opposizione visibilei-immaginario nei termini corpo/animo, la bellezza esteriore si pone necessariamente come seduzione frodolenta in quel suo “mostrar di rinchiudere... più che non apparisce di fuori”, vale a dire nel suggerire al primo colpo di vista – altro dal processo stendhaliano di “cristallizzazione” – una eccelsitudine spirituale la cui falsità può essere imputata indistintamente all’oggetto seduttore (“il nostro desiderio infinito di conoscere (cioè concepire), e di amare, non può essere mai soddisfatto dalla realtà”) [6] e al soggetto che la concepisce:
Non solo la facoltà conoscitiva, o quella di amare, ma neanche l’immaginativi a e capace delfinfinito, o di concepire infinitamente. ma solo dell indefinito. è di concepire indefinitamente [...] l’anima sente espressamente una certa angustia, una certa difficoltà, un certo desiderio insufficiente, un’impotenza decisa di abbracciar tutta la misura di quella sua immaginazione, o concezione o idea [...] perché l’anima sente e conosce o le pare, di non averla concepita e veduta tutta intiera, o che creda di non aver potuto, o di non aver saputo, e si persuada che sarebbe stato in suo potere di farlo, e quindi provi un certo pentimento, nel che ha torto in realtà, non essendo colpevole (Zib.,472, 4 gennaio 1821).
L’amore risulta così una variante sui generis dell’umana capacità di immaginare, dove l’oggetto di desiderio viene a configurarsi come ipotetico ricettacolo di sogni e pensieri insondabili non meno di quanto non ispiri all’amante idee infinite di una infinita felicità. Idea di un’idea, la passione non potrà quindi uscire dallo specchio imprigionante del pensiero (“amorosa idea”, “pensiero dominante”, “figlia della mente” ne saranno i significativi eteronomi), per la stessa ragione per cui la bellezza è mera “immagine”, cioè puro segno che rinvia a un contenuto non dato sdoppiandosi ad infinitum in copia e in originale [7].
Di qui il dilemmatico oscillare fra l’inno pseudoplatonico alla “donna che non esiste” (“vera” solo quale il pensiero l’“adombra”) e la dissacrazione misogina della “finta imago”: due estremi che si presuppongono a vicenda in sede logica per quanto appaiano disposti in successione cronologica secondo il tracciato inganno-disinganno: dapprima come inno alla mera possibilità astratta separata dalla sembianza sensibile (Alla sua donna):
Se dell’eterne idee
Luna sei tu, cui di sensibil forma
Sdegni l’eterno senno esser vestita
(v v. 154)
poi come perfetta coesistenza tra l’inganno dell’immaginazione e l’impressione dei sensi:
Ahi finalmente un sogno
In molta parte onde s’abbella il vero
Sei tu, dolce pensiero:
Sogno e palese error. Ma di natura.
Infra i leggiadri errori.
Divina sei: perché sì riva e forte,
Che incontro al ver tenacemente dura,
E spesso al ver s’adegua.
Né si dilegua pria, che in grembo a morte.
[...]
Altri gentili inganni
Soleami il vero aspetto
Più sempre infievolir. Quando più torno
A riveder colei
Della qual teco ragionando io vivo,
Cresce quel gran diletto,
Cresce quel gran delirio, ond’io respiro.
(Il pensiero dominante. vv. 108-116 123-129)
infine, come scomposizione impietosa della falsa corrispondenza (Aspasia):
Raggio divino al mio pensiero apparve,
Donna, la tua beltà [. ..]
[...] Vagheggia
Il piagato mortal quindi la figlia
Della sua mente, l’amorosa idea,
Che gran parte d’Olimpo in se racchiude,
Tutta al volto ai costumi alla favella
Pari alla donna che il rapito amante
Vagheggiare ed amar confuso estima.
Or questa egli non già, ma quella, ancora
Nei corporali amplessi, inchina ed ama:
Alfin l’enore e gli scambiati oggetti
Conoscendo, s’adira:
(Aspasia. vv. 33-47)
Destinata ad essere “copia” dell’immagine mentale, la bellezza femminile è quindi inautentica per definizione: perfetta quanto si voglia per sè, ma incapace di combaciare con la forma senza corpo dell’idea: anzi, estranea al soggetto che la concepisce nella stessa misura in cui, quale “figlia” della sua mente, può essere soltanto posseduta (cioè pensata) come idea. La romantica alleanza fra le “sensazioni indeterminate” e la felicità postulata da Novalis (Frammenti, 513), si rompe così in Leopardi riportando a galla l’antica quaestio delle due Veneri Visio corporalis/species intelligibilis).
A questo nodo risale infatti l’opposizione Io/Tu su cui si impernia La sera del dì di festa, giacchè la placida indifferenza della donna addormentata è condizione sine qua non del suo porsi come oggetto di contemplazione nel presuppsto implicito: ‘o si pensa o si è pensati’ (“e già non sai né pensi...”). I termini del problema dovrebbero perciò capovolgersi estraendo la non reciprocità dell’amore dal suo carattere mentale: la privazione di bellezza imposta agli animi sensibili, dalla separazione necessaria fra l’immagine e l’immaginazione: due conflitti erroneamente attribuiti nel 1821 all’ingiustizia distributiva del fatum:
Se mancassero altre prove che il vero è tutto infelice, non basterebbe il vedere che gli uomini sensibili, di carattere e di immaginazione profonda, incapaci di pigliar le cose per la superficie, ed avvezzi a ruminare sopra ogni accidente della vita loro, sono irre[si]stibilmente e sempre strascinati verso la infelicità? (Zib. 1974, 23 ottobre 1821).
L’uomo d’immaginazione di sentimento e di entusiasmo, privo della bellezza del corpo, è verso la natura appresso a poco quello ch’è verso l’amata un amante ardentissimo e sincerissimo. non corrisposto nell’amore [...] Egli sente subito e continuamente che quel bello, quella cosa ch’egli ammira ed ama e sente, non gli appartiene (Zib. 718-719, 5 marzo 1821) [8].
Se ripensare vuol dire riamare, non potrà stupire che Leopardi lasci fuori della sua teoria la donna beatrice provvista d’“intelletto d’amore”, e che i due maldestri tentativi in tale senso coincidano con la forma del dialogo inteso come comunicazione in mortis sulla base della reciproca sventura (Il sogno) ocome corrispondenza asimmetrica fra la pietas della bella donna e la supplica dell’amante infelice, parimenti generate dalla morte (“quanto, Elvir / Quanto debbo alla morte!”. Consalvo. vv. 85-86). Lo scambio amoroso può avvenire soltanto nel dominio dell’irrealtà (dunque della morte) e sotto forma di charitas: chi ama, muore: chi muore è compatito.
Anzi, se sognare vuol dire sperare in una gioia negata dalla vita, il destino mortale non potrà non apparire intimamente legato ai bei pensieri compagni di beltà, onde l’equazione bei pensieri = belle speranze = speranze deluse = morte delle speranze = morte della figura umana che le incarna, su cui si impernia il canto A Silvia. Tale la tesi esposta in una riflessione coeva dello Zibaldone, dove l’elogio della bellezza giovanile capace di trasportarci “in un altro mondo” si traduce nella dolorosa compassione per il presentimento di morte che incombe su quelle “divine” aspettative:
una donna di 20, 25 o 30 anni ha forse più d’attraits, più d’illecebre, ed è più atta a ispirare, e maggiormente a mantenere, una passione [...] Ma veramente una giovane dai 16 ai 18 anni ha nel suo viso. ne’ suoi moti, nelle sue voci, salti ec. non so che di divino, che niente può agguagliare [...] quella speranza vergine [...] che gli si legge nel viso e negli atti, o che voi nel guardarla concepite in lei e per lei [...] anche senza innamorarvi, senza interessarvi, fanno in voi un’impressione così viva, così profonda, così ineffabile, che voi non vi saziate di guardar quel viso, ed io non conosco cosa che più di questa sia capace di elevarci l’anima, di trasportarci in un altro mondo, di darci un’idea d’angeli, di paradiso, di divinità, di felicità. Tutto questo. ripeto, senza innamorarci, cioè senza muoverci desiderio di possedere quell’oggetto [...] Del resto se a quel che ho detto [...] si aggiunga il pensiero dei patimenti che l’aspettano, delle sventure che vanno ad oscurare e a spegner ben tosto quella pura gioia, della vanità di quelle care speranze, della indicibile fugacità di quel fiore, di quello stato, di quelle bellezze: si aggiunga il ritorno sopra noi medesimi: e quindi un sentimento di compassione per quell’angelo di felicità, per noi medesimi. per la sorte umana, per la vita, (tutte cose che non possono mancar di venire alla mente), ne segue un affetto il più vago e il più sublime che possa immaginarsi [...] (Zib. 4310-4311, 30 giugno 1828: corsivi miei).
Silvia non è delusa perché muore: muore perché pensa i pensieri del poeta concepiti “in lei e per lei”. Lo sdoppiamento della copia e l’originale si ripercuote così sulla tipologia femminile distinguendo una donna corporale e una donna spirituale, la prima destinata a sedurre, la seconda a perire. Dal labirinto non si esce: in un modo o nell’altro la dissociazione si moltiplica ad infinitum riportando dalla seduzione al nulla, dall’amore alla morte.
Difatti Thanatos allarga il suo spazio anche in proporzione del miraggio erotico quando, lasciandosi pienamente ingannare dalla somiglianza della copia, il soggetto si annulla nella propria idea [9]. Tale la premessa del Pensiero dominante, diversissima da quella da cui trae origine Alla sua donna,dove l’amorosa idea fa rinascere altri inganni puerili nella stessa misura in cui, figlia irripetibile di Venere Celeste, rimane senza pari sulla terra (“Ma non è cosa in terra / che ti somigli”. Alla sua donna. vv. 19-20):
Amore. figliuolo di Venere Celeste [...] non prima si volse a visitare i mortali, che eglino fossero sottoposti all’impero della verità [...] Quando viene in su la terra, sceglie i cuori più teneri e più gentili delle persone più generose e magnanime: e quivi siede per breve spazio: diffondendovi sì pellegrina e mirabile soavità, ed empiendoli di affetti sì nobili, e di tanta virtù e fortezza, che eglino allora provano, cosa al tutto nuova nel genere umano, piuttosto verità che rassomiglianza di beatitudine [...] Dove egli si posa, dintorno a quello si aggirano. invisibili a tutti gli altri, le stupende larve, già segregate dalla consuetudine umana [...] E siccome i fati lo dotarono di fanciullezza eterna, quindi esso, convenientemente a questa sua natura, adempie per qualche modo quel primo voto degli uomini, che fu di essere tornati alla condizione della puerizia. Perciocchè negli animi che egli si elegge ad abitare, suscita e rinverdisce per tutto il tempo che egli vi siede, l'infinita speranza e le belle e care immaginazioni degli anni teneri (Storia del genere umano).
La gentilezza del cuore implica, all’altezza delle Operette morali, la capacità di isolarsi dal reale coltivando l’arte della rêverie (tant’è vero che nel Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, l’inganno amoroso richiede le pareti isolanti di un carcere, il sogno o l’aiuto dei liquori spiritosi), mentre nel Pensiero dominante e in Amore e Morte il divario vero-falso si riduce al massimo nel reciproco potenziarsi del vedere, del sentire e del pensare (“Quanto più torno a riveder colei...”), rendendo indisgiungibili la vertigine del nulla e il turbine del desiderio (“Ratto d’intorno intorno al par del lampo; gli altri pensieri miei / tutti si dileguàr...”. Il pensiero dominante. vv. 16-18: “Poi,quando tutto avvolge / la formidabil possa, e fulmina nel cor l’invitta cura...”. Amore e Morte. vv.45-47).
Detto in altri termini, l’amore o produce dolci sogni allargando la distanza fra l’oggetto e la mente (onde la sua alleanza con la memoria), o si concentra in un punto visivo annullando la distanza fra i sensi e l’immaginazione. col conseguente trasformarsi nel suo opposto: il dolore. la paura, il senso di insufficienza [10]. Di qui il ripristino della tesi cas alcantiana dello sbigottimento in concordia discorde con l’idealizzazione platonica:
È proprio dell’impressione che fa la bellezza [...] su quelli d’altro sesso che la reggono o l’ascoltano o l’avvicinano, lo spaventare: e questo si è quasi il principale e il più sensibile effetto ch’ella produce a prima giunta, o quello che più si distingue e si nota e risalta. E lo spavento viene da questo, che allo spettatore o spettatrice, in quel momento, pare impossibile di star mai più senza quel tale oggetto. e nel tempo stesso gli pare impossibile di possederlo com’ei vorrebbe: perché neppure il possedimento carnale, che in quel punto non gli si offre affatto al pensiero, anzi questo n ’é propriamente alieno: ma neppur questo possedimento gli parrebbe poter soddisfare e riempiere il desiderio ch’egli concepisce di quel tale oggetto: col quale ei vorrebbe diventare una cosa stessa (come profondamente, benché in modo scherzevole osserva Aristofane nel Conv ito di Platone ): ora ei non vede che questo possa mai essere. La forza del desiderio ch’ei concepisce in quel punto, l’atterisce per ciò ch’ei si rappresenta subito tutte in un tratto, benché confusamente, al pensiero le pene che p. questo desiderio dovrà soffrire: perocchè il desiderio è pena, e il vivissimo e sommo desiderio. vivissima e somma, e il desiderio perpetuo e non niai soddisfatto e pena perpetua (Zib., 3444-3445. 16 settembre 1823 ).
Dove il pavor nasce sia dal senso di privazione (“star... senza quel tale oggetto”) sia dalla sovrabbondanza del desiderio rispetto ai limiti reali dell’oggetto (“neppur questo possedimento gli parrebbe poter soddisfare e riempiere il desiderio ch’egli concepisce di quel tale oggetto”). Una duplicità presente in Amore e Morte sotto forma del contrasto fra l’“infinita felicità” immaginata e il “deserto” della vita:
Forse gli occhi spaura
Allor questo deserto: a se la terra
Forse il mortale inabitabil fatta
Vede omai senza quella
nova, sola, infinita
Felicità che il suo pensier figura: («.34-39)
Ecco perché la nobiltà dell’animo si manifesta all’altezza di questo canto e del precedente, non già come capacità di coltivare “gentili inganni”, ma come eroismo di fronte al nulla e coraggio di morire:
Giammai d’allor che in pria
Questa vita che sia per prova intesi.
Timor di morte non mi strinse il petto.
Oggi mi pare un gioco
Quella che il mondo inetto.
Talor lodando, ognora abborre e trema,
Necessitade estrema:
E se periglio appar, con un sorriso
Le sue minacce a contemplar m’affiso.
(Il pensiero dominante. vv. 44-52)
Né cor fu mai più saggio
Che percosso d’amor, né mai più forte
Sprezzò l’infausta vita.
Né per altro signore
Come per questo a perigliar fu pronto:
(Amore e Morte, vv. 17-21)
La bipolarità di Amore e Morte nasce, anzi precisamente da questa ambivalenza della passione, che richiama la morte sia per via indiretta (attraverso il senso di nullità presentito in sua assenza), sia direttamente in quanto sentimento doloroso per se la cui sete inappagata (“fier disio” e rugghiante “procella”) si ritorce contro il soggetto spingendolo a trovare “quiete” in grembo a morte.
Non è che Leopardi sia un “sombre amant de la mort”. è che la morte deriva immediatamente dalla dialettica della passione, che porta, morendo, ad annullare il nulla da essa stessa prodotto. In ogni caso la contraddizione insita nella brama insanabile si può risolvere soltanto erotizzando la negazione stessa (cioè, portando la dialettica all’estremo). oppure uscendo dal suo circolo col sottoporre il meccanismo del pensiero a un’analisi dissacrante. Il disamore ha difatti in Leopardi un carattere squisitamente cerebrale perché non amare significa innanzitutto distinguere ciò che l’immaginazione ha confuso: il pensiero dall’idea (“l’errore e gli scambiati oggetti / conoscendo”, Aspasia. vv. 46-47 l’idea dal referente corporale (“A quella eccelsa imago / sorge di rado il femminile ingegno”, ivi, vv. 4849).
Rotto l’incanto della “dolce somiglianza”, l’intelletto si libererà, quindi dal “caro immaginar” per guardare spassionatamente i propri meccanismi. Il coraggio della verità si rivolge, insomma, allo studio dell’autoinganno risolvendo il topos del “favola fui” (“a te dinanzi / me timido tremante (ardo in ridirlo / di sdegno di rossor)...”. Aspasia. vv. 94-96) in un restauro dell’intelligenza: “dopo un lungo / vaneggiar, contento abbraccio / senno con libertà” (ivi, vv. 104-106).
Altro non è Sopra il ritratto di una bella donna se non una forma estrema di autoanalisi ad opera del pensiero, che interroga se stesso sulla propria capacità di immaginare.
Il fatto che la bella donna appaia pietrificata dalla morte, comporta due importanti conseguenze: da un lato elimina dal conto la spiritualizzazione dell’interno femminile concentrando l’inganno sugli occhi e sul pensiero dello spettatore; dall’altro sostituisce il binomio corpo/spirito con lo sdoppiamento del corpo in “simulacro” seducente e brutta verità nascosta “sotterra’’.
Il mito della fanciulla morta come incarnazione dell’inganno dei sogni “concepiti in lei e per lei”, sparisce così per lasciare allo scoperto i termini essenziali del problema: la falsità della bellezza in quanto tale; cioè i1 suo carattere di mero segno (“simulacro”) di un contenuto non dato [11] che dissolvendo in nulla le nostre aspettative le trasforma in bruttezza. La morte diventa, insomma, per antonomasia, morte della bellezza.
A partire da questo enigma (che la bellezza sia brutta materia corruttibile), l’analisi affronta però un altro e più impenetrabile mistero: che la materia possa suscitare “eccelsi, immensi pensieri e sensi” rendendo inseparabili l’“ammirabil concetto” e il corpo seduttore (“dotto concento”).
Domande senza risposta precisamente perché portano a galla il nucleo opaco del dilemma: la materia che sente e pensa.
I Canti non soltanto contengono una teoria dell’amore, ma alla fine del percorso risolvono la passione in teoria mettendo il pensiero al centro del meccanismo di sdoppiamento. Il pensiero pensato scopre allora che lo scambio simbolico fa parte della sua essenza: “misterio eterno dell’esser nostro” e la meraviglia si restaura di fronte a questa nuova e superiore vertigine, ma ormai slegata dalla seduzione, che, anzi, il poeta riconosce come tale precisamente perché ne ha sondati i segreti meccanismi.
Si capisce così che, uscito dall’amore, egli gli innalzi ancora un inno quale mezzo supremo di “conoscimento”, perché soltanto chi è stato davvero illuso, diventa, pensando ed amando, padrone dell’illusione:
il conoscimento e il possesso di se medesimi suol venire o da bisogni e infortuni, o da qualche passione grande, cioè forte: e per lo più dall’amore: quando l’amore è gran passione: cosa che non accade in tutti come l’amare. Ma accaduto che sia, o nel principio della vita, come in alcuni, ovvero più tardi, e dopo altri amori di meno importanza, come pare che occorra più spesse volte, certo all’uscire di un amor grande e passionato, l’uomo conosce già mediocremente i suoi simili, fra i quali gli è convenuto aggirarsi con desiderii intensi, e con bisogni gravi e forse non provati innanzi: conosce ab esperto la natura delle passioni, poiché una di loro che arda, infiamma tutte l’altre: conosce la natura e il temperamento proprio: sa la misura delle proprie facoltà e delle proprie forze: e ormai può far giudizio se e quando gli convenga sperare o disperare di se, e per quello che si può intendere del futuro, qual luogo gli sia destinato nel mondo. In fine la vita a’ suoi occhi ha un aspetto nuovo, già mutata per lui di cosa udita in veduta, e d’immaginata in reale: ed egli si sente, in mezzo ad essa, forse non felice, ma per dir così, più potente di prima, cioè più atto a far uso di se e degli altri (Pensieri. LXX).
Note
____________________________
[1] La formula figura nella strofa XIX della lirica Après une lecture (1842): «O toi quiappelle encore ta patrie abaissée, / dans ta tombe précoce a peine refroidie, sombre amant de la Mort, pauvre Leopardi».
[2] «Ad atti egregi e sprone / amor, chi ben l’estimo, e d’alto affetto / maestra èla beltà» (Nelle nozze della sorella Pao/ina, vv. 46-18);«Alle sembianze il Padre, / alle amene sembianze eterno regno / diè nelle genti: e per virili imprese, / per dotta lira o canto, / virtù non luce in disadomo ammanto,) Ultimo canto di Saffo, vv. 50-54), due asserti problematizzati daLeopardi in Zib. 1594, dove, pur affermando teoricamente l’armonia fra bellezza e virtù, la nega nella pratica alla luce dell’esperienza storica: «La bellezza è naturalmente compagna della virtù L’uomo senza una lunga esperienza non si avvezza a credere che un bel viso possa coprire un’anima malvagia [...] la natura ha posto un’effettiva corrispondenza tra le forme esteriori e le interiori, e se queste non corrispondono, sono per lo più alterate da quelle ch’erano naturalmente. Pure è certo che i belli sono per lo più cattivi [...] Un brutto [...] più facilmente s'incammina alla virtù» (Zib., 1594, 31 agosto 1821).
[3] Secondo la cronologia, parte nota parte congetturale, la disposizione seguirebbe invece il seguente percorso: Il primo amore (1817), Il sogno (1820-1821?), Nelle nozze della sorella Paolina (ottobre-novembre 1821), Ultimo canto di Saffo (maggio 1822), Alla sua donna (settembre 1823), Il pensiero dominante (1831 o 1832). Consalvo (1832?), Amore e Morte (1832?), Aspasia (1834?), Sopra il ritratto di una bella donna (1834-1835?)
[4] Ma cfr. anche questi due asserti di Zib. 59: «Quando l’uomo concepisce amore tutto il mondo si dilegua dagli occhi suoi». Io non ho mai sentito tanto di vivere quanto amando».
[5] Anzi lo sdoppiamento visibile occulto si ripercuote anche sul corpo: «E come la considerazione dello spirito che è cosa occulta, influisce su quella del corpo, e rende misteriosi e vaghi i sentimenti e le idee che da questo naturalm. e pincipalm. hanno origine [...] così la considerazione del corpo divenuto anch’esso cosa, p. la maggior parte, occulta e sottoposta all’immaginazione altrui più ch’ai sensi, rende misteriosi ec. e spiritualizza nel modo più naturale i sentimenti e le idee ec. (Zib.. 3915-3916. 26novembre 1823).
[6] Col seguente corollario: «solamente può essere soddisfatto dalle illusioni (o false concezioni o false persuasioni di conoscenza e di amore, e di possesso e godimento)». Zib.. 388. 18 dicembre 1820.
[7] È proprio il caso di ricordare la tesi di Roland Barthes sull’equivalenza fra l'’innamorato e l'artista, parimenti votati all’immagine come sostituto della cosa (cfr. Fragments d'un discours amoureux. Paris, Seuil, 19. p. 159): un principio già messo in relazione da Antonio Prete con la teoria romantica dell'amore (cfr. A Prete, La passione d'amore e la scrittura romantica, in AA. VV., Storia delle passioni, a cura di Silvia Vegetti Finzi. Bari, Lateza, 1995, p. 188).
[8] Cfr. nello stesso Zib.. 2486.21 giugno 1822.
[9] “La séduction est ce dont il n’j a pas de représentation possible, parce que la distance entre le réel et son double, la distorsion entre le Même et l'Antre y est abolie” (J.. Baudrillard, De la séductions. cap. I’ll be your mirror Paris, édition Galilée, 1979. p. 95).
[10] Non dimentichiamo che il dolore è sinonimo di amore nell’inno Ad Arimane. “passioni piene di dolore e disperazione: amore”.
[11] “immagine di un’immagine” la chiama, giustamente Oreste Alacri nella “postilla” Leopardi o della ‘beltà’ pietrificata. cfr. O. Macrì. La vita della parola. Studi su Ungaretti e poeti coevi, a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni. 1988. pp. 60-66.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| © 1996 - Tutti i diritti sono riservati Biblioteca dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2005 |