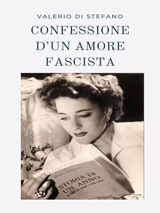
Amazon - Website

![]()
Edizione di riferimento:
Antonio Ranieri, Notizia della morte del Conte Giacomo Leopardi, apparsa sul giornale “Il Progresso”vol. XVII, anno VI, Napoli, 1837 a cura di Angelo “quijote” Fregnani, AQF Cesena 2009, località Sasso di Oriola via, Garampa, 9862 - © 2009 - Tutti i diritti sono riservati all'autore
Salve o fedel, che di tua nave a prua
Sol virtù candidissima volesti,
La qual ti scorse ove non son confini.
(M. G. Guacci Nobile, 1838)
Si pubblica questo brevissimo scritto, in quanto poco citato anche dai maggiori biografi leopardiani, e quasi mai ripresentato nel suo dettato originale [1].
Il 17 giugno 1837, a tre giorni dalla morte di Giacomo Leopardi, il Ranieri scriveva al conte Monaldo per annunciargli il triste evento. Pochi giorni dopo, il 26 giugno, riprendeva la penna per descrivergli in dettaglio gli ultimi giorni del poeta. Con più misura, il 18 luglio, gli accennava e accludeva: «la prima notizia che ho mandata del mio adorato amico a questo nostro giornale letterario intitolato il Progresso» (sc. “Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti”, vol. XVII, Anno VI, n. 33, quaderno di maggio, Napoli, dalla Tipografia Plautina, 1837, p. 166 s.).
Si tratta di un breve necrologio, che da qualcuno, non del tutto a torto, è stato definito la miglior cosa scritta dal Ranieri su Leopardi. E certo non ha né la pesantezza né la prolissità della Notizia [2] premessa all’edizione fiorentina del ‘45, e nella sua essenzialità, merita di essere conosciuto. Se non altro perché offre comunque informazioni essenziali sulla tradizione testuale delle opere leopardiane; nonché qualche anticipazione dell’intricata psicologia del sodale di Giacomo, cui si farà accenno in qualche nota. Le lettere citate del Ranieri, qui e nelle note al testo, possono leggersi negli ancor fondamentali G. Piergili, Nuovi documenti intorno alla vita e agli scritti di Giacomo Leopardi, Firenze, Successori Le Monnier, 1892, N. Serban, Lettres inédites relatives a G. L., Paris, Champion, 1913.
Cesena, febbraio 2009 Angelo Fregnani
Busto di Giacomo Leopardi eseguito, nel 1898, da Giulio Monteverdi, per le celebrazioni del centenario della nascita del Poeta. Tratta da WikimediaCommons, l’immagine chiaramente non è riproduzione diretta del monumento (oggi nel Palazzo Comunale di Recanati), ma di una cartolina celebrativa, connessa all’evento. Ed evento eccezionale e irripetibile veramente fu, nobilitato dall’orazione ufficiale di Giosuè Carducci e dal poema musicale A Giacomo Leopardi del Mascagni, diretto dallo stesso Maestro; e, non fosse altro, dall’inaugurazione stessa, in quell’anno, del Palazzo Comunale medesimo.
Conte Giacomo Leopardi.
Il dì quattordici di giugno, a ventun’ora [3], d’un’idropericardia [4] che da gran tempo lo minacciava, mancò fra noi all’Italia, anzi a tutto il mondo civile, uno de’ più potenti ingegni che sieno surti a questi ultimi anni; il conte Giacomo Leopardi, di Recanati, filosofo e filologo di rarissima eccellenza, prosatore più che sublime, ma poeta incomparabile. Il grido del suo nome, già grandissimo non solo in Italia, ma eziandio in Francia, in Germania e in Inghilterra, non più soffocato dall’invidia, che non suol durare oltre la tomba, sorvolerà i secoli finché sarà memoria fra gli uomini del bello e del grande. La favilla divina che s’accese sotto quella giovane chioma, non vi fece dimora oltre a trentott’anni, undici mesi e tre dì [5]. Byron morì a trentasei anni. A fiamme così vive non è dato di risplendere più lungo tempo sulla terra, perché sarebbero di leggieri oltrepassati i confini che il fato prepose all’ingegno umano.
L’infausta stagione che corre [6], e il dolore stesso dell’irreparabile perdita che abbiamo fatta, non ci consente fra tanto pubblico e privato lutto, di parlare parole degne d’un tanto uomo [7]. Ma nel quaderno che seguirà [8] speriamo di poter contentare la giusta curiosità dell’universale in tutto ciò che concerne la vita e le opere di questo portento d’ingegno e di sapere. Per ora ci è dolce di poter annunziare, che oltre alle cose già stampate altrove e qui, ci rimane di lui un poemetto in ottava rima e in otto canti, intitolato: I paralipomeni della Batracomiomachia di Omero, che, a parer nostro, sono le più belle stanze scritte in Italia dopo l’Ariosto [9]; due nuovi canti lirici [10], pieni, al solito, d’eleganza, d’affetto, di filosofia, un volumetto di pensieri morali [11], tutti sciolti e vari d’argomento, d’ una profondità e d’un’eccellenza di dizione da recare stupore; tre nuovi dialoghi [12]; e due versioni dal greco, il Manuale d’Epitteto e i Morali d’Isocrate [13], entrambe ornate di due preamboli. Queste due versioni trovansi appresso il dottor Pietro Manni, dal quale non dubitiamo che saranno rendute subito [14], per essere trasmesse al Baudry, libraio in Parigi, che si propone di dare fra breve un’edizione compiuta di tutte le opere [15] dell’impareggiabile defunto.
Il suo corpo, chiuso in una splendida cassa, fu, con quella pompa che le condizioni del tempo potevano consentire, trasferita [sic] nella chiesa di San Vitale fuori la Grotta detta di Pozzuoli, dove le sue ossa riposano non discosto da quelle di Virgilio e di Sannazzaro [16]. Quivi gli sarà rizzato un monumento, se non degno dell’altezza del suo ingegno, bastante almeno a far fede appresso la posterità della giusta venerazione in cui l’ebbero i Napoletani.
A. R.
LOGON HONORATUS DAUMIER PINXIT
CVPERTINI·PPC·MALVM·PDF·CREAVIT
EDIDIT·ANGELVS·FERNIANVS·QVIXANVS·FOROLIVIENSIS
MENSE·MARTIO·ANNO·MMVIIII
APVD·SAXVM·ORIOLÆ·CÆSENAE·SVBVRBIVM
MVLTIVERSI·MICAE
Note
________________________
[1] Non so d’altri che Novella Bellucci, G. Leopardi e i contemporanei: testimonianze dall’Italia e dall’Europa in vita e in morte del poeta, Firenze, Ponte alle Grazie. 1996, p. 168 s.
[2] Su di essa in certo qual senso coglie nel segno – al di là delle intenzioni non denigratorie – la definizione dell’amico Marc Monnier, L’Italie est-elle la terre des morts?, Paris, Hachette, 1860, p. 140: «La notice de M. Ranieri […] est un curieux travail d’anthropologie». Altri sarà più critico di fronte alla sua insipienza, che solo in parte può essere spiegata dalle maglie della censura toscana. Ranieri se ne giustificherà in anticipo, dicendo di aver dovuto mirare alla «quadratura del cerchio» (lett. al De Sinner, 1 gennaio 1845 = Piergili 293 ss.); ma ciò sa molto, per usare una sua espressione, di excusatio non petita. Per maggiori particolari cfr. F. Ridella, Una sventura postuma di G. L, Torino, Clausen, 1897, pp. 77-83.
[3] Vale a dire, secondo l’uso napoletano, circa le cinque della sera (cfr. A. R. Sette anni di sodalizio con G. L., Giannini, Napoli, 1880, p. 61 = cap. XXXVII: «S’era alle ventun’ora, come si diceva allora qui, cioè, alle ore cinque pomeridiane del dì quattordici»): ora che ricorda, si perdoni la citazione epidermica ed estemporanea, Garcia Lorca, e di riflesso il toro-David di Pasolini che “va dolce alla morte” (Poesie a Casarsa).
[4] Cfr. lett. a Monaldo 26 giu. 1837 (= Piergili 241 ss.): «il suo male è stato idropisia di cuore, ovvero acqua nel pericardio»; lett. a de Sinner 28 giu. 1837 (= Piergili 267 ss.) «egli spirò […] d’un idrotorace che lo minacciava da gran tempo»; Notizia lemonnieriana premessa all’ed. 1845 delle Opere di G. L. vol. I: «le acque, che già da gran tempo tenevano le vie del cuore, abbondarono micidialmente nel sacco che lo ravvolge, ed oppressa la vita alla sua prima origine, quel grande uomo rendette sorridendo il nobilissimo spirito»; Supplemento alla notizia, in Opere di A. R., vol. III, Milano, Guigoni, 1864, pp. 159 ss.: «nel Trentasette morì poscia a Napoli d’idropisia».
[5] Il che rimanderebbe erroneamente all’11 luglio 1798. Ma nella lettera del 18 luglio 1837 (= Piergili, 249 ss.) Ranieri confesserà a Monaldo Leopardi di non essere affatto certo del giorno natale del poeta («Ella deve avere ancora la bontà di darmi una notizia esatta di tutto ciò che può essere importante a chi deve scrivere una vita compiuta di Giacomo; della sua nascita, che non vorrei avere sbagliata»). Dubbio che implicitamente lo contraddice, quando un mese e mezzo dopo dichiara al De Sinner, romanticamente, di aver conosciuto il Leopardi «in Firenze il dì 29 giugno 1827, anniversario della sua nascita» (Piergili p. 274 = lett. del 2 sett. 1837: stupisce un po’ che lo smaliziatissimo Ridella, op. cit., p. 16, abbia sorvolato sull’incongruenza).
[6] Allude al colera che imperversava in Napoli.
[7] tanto uomo: sintagma caro al Ranieri che lo userà in più d’un luogo nei Sette anni di sodalizio (capp. VII, XIII), nelle lett. al le Monnier (24 giugno 1844 = Serban p. 74, a proposito del Niccolini; 12 dic. 1844 = Serban p.117, rif. a Leop.) e quasi certamente nel quotidiano, tant’è che il Settembrini lo usò nelle sue Ricordanze, attribuito al Leopardi, proprio a seguito di un colloquio col Napoletano intorno alla contrastata sepoltura del sodale (cap. XI, ultimo paragrafo). Era comunque nesso tutt’altro che inusuale (ess. in Serban pp. 110, 111 lett. di Pellegrini a de Sinner).
[8] Non mi risultano ulteriori articoli. Risalta invece, da parte del Ranieri, l’arte sopraffina delle calende greche. Sempre ch’io non erri, ma al momento ho conoscenza del necrologio della “Biblioteca Italiana” (20 luglio) e di quello del Carrer su “Il gondoliere” (22 luglio), ho notizia di altri scritti ma non di ulteriori note del Ranieri sui numeri successivi del “Progresso”.
[9] E il Tasso? Omissione tanto più assurda a chi consideri qual legame sentimentale affettivo provava Giacomo nei confronti dello sfortunato cantore della Gerusalemme, su cui basti rimandare alla celeberrima lettera al fratello Carlo, in Roma, 20 febbraio 1823 (Epistolario, ed. Brioschi-Landi, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, n. 520).
[10] La Ginestra e il Tramonto della luna, pubblicate, per la prima volta, nella lemonnieriana del 1845 (F45). Ha rilevanza testuale per la tradizione dei Canti che né qui, né nella lett. al de Sinner cit. del 28 giugno del ‘37, Ranieri accenni minimamente alla satira I nuovi credenti. Più tardi egli dubiterà, se inserirla o no nei Canti.
[11] I centoundici Pensieri, editi anch’essi, per la prima volta, nella lemonnieriana del ‘45.
[12] Saranno aggiunti alle Operette Morali nell’ed. 1845: Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco, Il Copernico, Dialogo di Plotino e di Porfirio.
[13] Al solito, prima ed. in F45.
[14] Il Manni, corrispondente del Leopardi (cfr. lett. nn. 1891, 1892, 1893, 1935, 1937 nell’ed. Brioschi-Landi), aveva avuto in pegno, a garanzia di un credito, le due traduzioni. Il Ranieri ebbe il suo da fare per recuperarle; cfr. partic. lett. a Monaldo Leopardi, cit. 18 luglio 1837; lettera al De Sinner, cit. 28 giugno 1837, da cui risulta che l’approccio del Ranieri ha del surrettizio, ché egli cita ripetutamente e pubblicamente il Manni, stuzzicandone, a suo dire, la vanità, ma mettendolo in realtà di fronte alle responsabilità morali verso il defunto e verso la pubblica opinione; a sua giustificazione, v’è però a dire che si fece – sempre che il Manni non l’abbia abbonato alla memoria - carico del debito del sodale (cfr. Ridella, op. cit., p.62).
[15] Tale edizione poi non si farà, forse per i maneggi del Tommaseo e del suo ambiente. Il Baudry avrà comunque il merito di pubblicare i Paralipomeni (Parigi, 1842), ch’era impensabile, per la loro carica eversiva, dare alle stampe in Italia.
[16] Con poche o punte varianti questa descrizione si ripropone nei Sette anni di sodalizio (partic. Supplemento, cit., e ivi riprodotto ad fin.), nella più volte citata lettera al de Sinner del 28 giugno, e nella lettera a Monaldo a tre giorni dal decesso (= Piergili 237 ss.; per inciso, in tutti e tre gli scritti si ritrova la grafia Sannazzaro, con doppia zeta, cui oggi vien preferita la scempia). Alla nota 10 al cap. XXXVII del Sodalizio, potranno trovarsi notizie sul monumento sepolcrale. Cui qui si aggiunge che, alla croce cristiana avrebbe dovuto sostituirsi l’immagine della nave che giunge al porto, come nei bei versi della Guacci Nobile premessi a questa edizioncina.
![]()
|
|
|
© 1996 - Tutti i diritti sono riservati Biblioteca dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi Ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2010 |